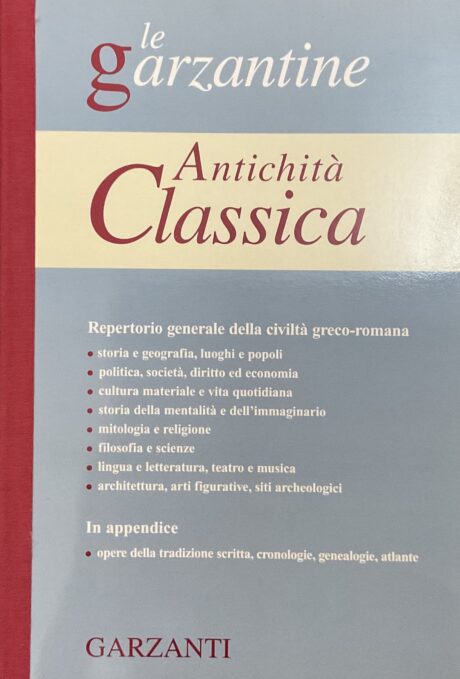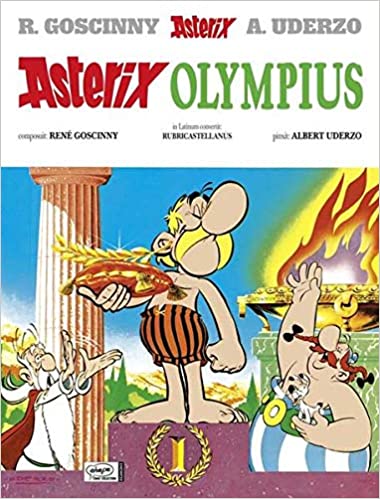Agli albori del calcio: sferomachia, episciro e arpasto
(a cura di Antonio Mastrogiacomo)
Vi raccontiamo una storia da prendere non troppo sul serio, eppure da conoscere per rilevare radici antiche per quel gioco che oggi conosciamo come “calcio”; sappiate insomma che la proposta decisa di un motivo classico a sostegno del gioco è da registrare compiutamente nel trapianto dell’episciro greco (ἐπίσκυρος) al romano arpasto in riferimento a regole pressoché identiche.
Esisteva anche la sferomachia (σφαιρομαχία), un gioco con la palla diffuso nell’antica Grecia e nel Peloponneso, che secondo alcuni studiosi sarebbe stato però più simile al pugilato che al gioco della palla, inteso come “calcio”.
Dalla sferomachia e l’episciro… all’arpasto
L’arpasto (ἁρπαστόν) deriva il nome dal verbo greco ἁρπάζω (rapio) e consisteva infatti nello strapparsi la palla attraverso una folla di contendenti.
La fortuna e la varietà dei giochi di palla ci garantiscono che i legionari di Cesare conoscevano l’arpasto quando attraversarono il Canale al comando del geniale umanista e dovettero ricordare per allietare le ore di libertà, calciando un oggetto rotondo.
Pare che questi degni militari si battessero già in squadre regolari, divise con criterio ed equità. Il loro contributo ai successivi sviluppi della storia del calcio è stato esagerato durante il periodo fascista per amore di retorica imperiale; ma è indubbio che i fieri britanni impararono il gioco dalle truppe di occupazione e vi si appassionarono tanto da continuare a praticarlo mentre nella patria dei legionari l’arpasto andava malinconicamente declinando: attesta una curiosa notizia che i britanni abbiano segnato una memorabile vittoria contro la rappresentativa dei legionari nel 276 d.C.
Il calcio fiorentino
Tagliando la linea del tempo per arrivare direttamente al Rinascimento e accordare l’urgenza di un motivo classico a sostegno degli usi e costumi più tardi rimodulati in senso moderno, è suggestivo considerare come nel registrare l’atto di nascita del melodramma, l’Euridice di Peri e Caccini (1600) si accorda ai festeggiamenti per le nozze tra Maria de’ Medici e il re di Francia Enrico IV di Navarra secondo una prassi non lontana per partite che pure si disputarono in occasione di matrimoni principeschi e visite, aventi per teatro non una sala di Palazzo Pitti bensì la piazza di Santa Croce o anche Santa Maria Novella – comunque uno spiazzo di cento metri per cinquanta.
Se gli storici non escludono che in riva all’Arno il calcio abbia avuto origine da competizioni poco strutturate sviluppate per le strade e le piazze della città, il gioco fu presto fatto proprio dall’aristocrazia che lo adottò come uno dei suoi passatempi preferiti.
Si può a tal proposito fare affidamento alla tradizione diretta e trovare conforto nelle parole dello stesso Giovanni de’ Bardi quando scrive:
Oltre all’antichità è nobilissimo questo gioco per lo soggetto, per la natura e per l’utilità. Il soggetto suo erano le persone degl’Eroi, le quali come s’è detto quello solo, come più nobile degli altri, è più degno giuoco, s’esercitavano; e noi similmente il fiore della Nobiltà, come a suo luogo diremo a quello che scegliamo. (De’ Bardi 1580: 6)
Sul dato agonistico è giocato tutto l’esordio, in rapporto agli esercizi dell’animo «che farebbero l’uomo vivo secondo il parer di Guido Cavalcanti, buon filosofo dei tempi suoi». Rispondendo implicitamente al dedicatario del discorso, il gran duca di Toscana, De’ Bardi introduce agli esercizi del corpo articolandone una rassegna la cui premessa caratterizza la dovuta storicizzazione del caso proposto:
Ma i cattivi pensieri che l’ozio, e le morbidezze producono svegliandoci, e quasi spoltrendoci, convertono in desideri di virtù e di laude: di qui è nata quella gran diligenza e cura che non veggiamo aver avuto sempre l’antiche città bene ordinate di tenere i popoli occupati, e trattenuti nei giuochi e nei vari esercizi. (Ibidem: 3)
Prendendo le mosse dalla Sparta di Licurgo, il percorso porta alla definizione del gioco del calcio fiorentino, per una motivazione particolarmente avvertita dall’autore:
Del calcio, che oggi è proprio giuoco nostro fiorentino, di cui niuno, ch’io sappia sino ad ora ha trattato, mi volgerò a ragionare; al fine che se la malvagità del tempo ovunque facesse che egli si perdesse, come è dell’arte istrionica, dei cori, dei Mimi, dei Rithmi, della musica antica, della Magia, e della Cabala, e di molte altre arti e scienze è avvenuto, almeno ne rimanga questo mio libretto come un piccolo monimento à coloro che dopo noi verranno se però il libro avrà lunga vita. (Ibidem: 4)
A cagione di questo carattere speculativo connaturato al gioco, Bardi così prosegue:
Dico adunque che gli antichi solevano accedere alla virtù non pure con la severità delle leggi e con gli ammaestramenti della Filosofia ma con la Poesia, con la Musica e con diverse arti piacevoli e giuochi allegri intra i quali quello della palla dei lacedemoni ritrovato. (Ibidem: 4)
Conclusioni tra sferomachia, episciro e arpasto

Finisce qui il nostro “small tour” tra sferomachia, episciro e arpasto… alla ricerca delle antiche origini di questo sport che solo oggi si è trovato ad essere senza tempo.
Eppure avremo modo di tornare su questo argomento declinando senza troppe difficoltà tra nazioni e tempi diversi.